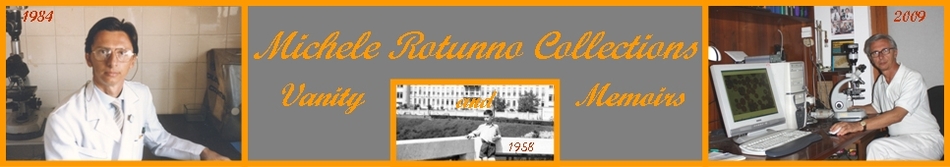Considerazioni etico deontologiche e cure palliative in ambito uro-nefrologico
Le stanze dei ricordi - Racconti nefrologici > Livello 11
Considerazioni etico deontologiche e cure palliative in ambito uro-nefrologico.
(Master Universitario di 1° livello in Cure Palliative – Novara 15.01.04)
Pier Luigi Cavalli
Urologia e Nefrologia: uno sguardo al passato e al presente
Mentre l’Urologia ha una lunghissima tradizione alle spalle, la Nefrologia è una disciplina più recente.
Fino al XVIII secolo, le malattie dell’apparato urinario conosciute erano costituite quasi esclusivamente dalla calcolosi e fin dall’antichità si praticavano manovre chirurgiche per l’estrazione di calcoli vescicali.
Nel Giuramento di Ippocrate si afferma:
“Non opererò i malati di calcoli, lasciando tal compito agli esperti di quell'arte”.
Per Galeno l’elenco delle malattie renali si circoscriveva nella sola: “lithiasis, id est calculi morbus, nephritis appellatus”. Come si può notare il termine “nefrite”, che oggi indica malattie differenti, faceva già parte del vocabolario dell’urologia.
Con tutta probabilità il dettato di Ippocrate non è il primo riconoscimento dell'urologia come specialità, ma una presa di distanza, degna di un cattedratico ante litteram, nei confronti della manovalanza che praticava questa tecnica chirurgica (chirurgia vuoi dire appunto lavorare con le proprie mani e non con la mente). L’estrazione cruenta dei calcoli e il cateterismo vescicale furono praticati fin dall’antichità e, ancora, lungo tutto il Medioevo e il Rinascimento. Famosa è rimasta la destrezza dei cerretani e dei norcini (questi ultimi si erano fatti la mano castrando i maiali) nella pratica di queste tecniche che, ovviamente, non erano né innocue né indolori. Da questo punto di vista, tuttavia, le cose per lungo tempo non migliorarono, anche quando tale pratica passò di mano e fu affidata ai medici.
L’urologia nasce dunque come specialità chirurgico-strumentale e tale rimane tuttora.
La nascita della nefrologia moderna si può invece far risalire all’inglese Richard Bright che, al Guy’s Hospital di Londra nel 1825, cominciò a interessarsi delle alterazioni strutturali dei reni nei casi di albuminuria, idropisia e ritenzione urinaria e in tre anni illustrò, al tavolo autoptico, ventitré casi deceduti per tali sintomi. I suoi rilievi furono pubblicati nel 1827 e, in tal modo, Bright si costruì la fama imperitura di "Padre della Nefrologia". Le nefriti croniche diventeranno malattie eponimiche e diventeranno note anche col titolo di "morbo di Bright".
La Nefrologia è sempre stata una disciplina piuttosto languida come risultati terapeutici raggiunti e la dialisi, al suo nascere, rappresentò uno straordinario strumento di legittimazione per questa disciplina. Essa, infatti, dimostrò di essere l’arma terapeutica più efficace nel trattamento dell’insufficienza renale ma, a tutt’oggi, rappresenta anche il fallimento delle cure farmacologiche.
Insufficienza renale
Per insufficienza renale si intende la compromissione della funzionalità del rene nelle sue componenti
- Escretoria.
- Regolatrice del bilancio idroelettrolitico.
- Endocrina.
La funzione escretoria, ossia l'eliminazione dei prodotti del catabolismo, è tra le funzioni più importanti del rene. In particolare esso ha un ruolo insostituibile nell'eliminazione dei prodotti terminali del catabolismo proteico (urea, creatinina, acido urico, ecc.) sostanze che, per il fatto di contenere uno o più atomi di azoto nella loro molecola, sono anche dette scorie azotate.
Altrettanto importante è, tuttavia, la funzione che il rene svolge nella regolazione del bilancio idro-elettrolitico, mediante la quale esso contribuisce in maniera determinante a mantenere costante la composizione del mileu interieur. Accanto a queste due funzioni, escretoria e di regolazione dell'omeostasi idro-elettrolitica, il rene svolge un ruolo anche:
- nella regolazione della pressione arteriosa, mediante la secrezione di renina e di prostaglandine;
- nel processo di maturazione dei globuli rossi, mediante la secrezione di eritropoietina;
- nel ricambio del calcio e del fosforo, elaborando i metaboliti attivi della Vitamina D, con conseguenti influenze soprattutto sul metabolismo del tessuto osseo.
Insufficienza renale acuta (IRA) e Insufficienza renale cronica (IRC)
A seconda della rapidità con cui si instaura, l’insufficienza renale viene distinta in
- Acuta (IRA)
- Cronica (IRC)
Possiamo definire l'insufficienza renale acuta come una rapida riduzione delle funzioni renali, in particolare di quella escretrice, che si instaura entro poche ore o pochi giorni in pazienti con reni precedentemente normali, e che conduce ad una perdita dell'omeostasi dell'organismo.
La compromissione funzionale è spesso accompagnata da una contrazione della diuresi giornaliera che, se inferiore a 400 ml, si definisce oliguria e, se inferiore a 50 ml, anuria.
Sino a venti anni fa circa l'oliguria o l'anuria erano considerate sintomi fondamentali dell'IRA ma, ultimamente, le migliorate tecniche di rianimazione e di supporto, oltre all'impiego precoce dei diuretici osmotici o dell'ansa e dei vasodilatatori renali, hanno reso sempre più frequente l'IRA non oligurica, altrimenti detta "a diuresi conservata". La frequenza di questa forma varia infatti, a seconda delle casistiche, dal 25 all'80%.
Il rapido e progressivo accumulo nel sangue dei prodotti del catabolismo azotato, anche in presenza di una diuresi normale o addirittura aumentata, resta pertanto il segno patognomonico di insufficienza renale acuta.
Abbiamo detto che la rapidità con cui si instaura l'insufficienza renale è il criterio che permette di distinguere l'insufficienza renale acuta (IRA) dall' insufficienza renale cronica (IRC). Mentre la prima si instaura nel giro di poche ore o, al massimo, di pochi giorni, quest'ultima si manifesta più lentamente, nel corso di mesi o di anni, ed è il punto di arrivo della maggior parte delle malattie renali.
Il termine di uremia (letteralmente: presenza di urina nel sangue) viene usato per indicare il quadro clinico dell'insufficienza renale grave. Questo termine si riferisce all'aumento di urea nel sangue e si basa sul presupposto che questa sostanza svolga un'azione tossica. In realtà l'azione tossica dell'urea è certamente inferiore a quella di altre scorie azotate, come la metilguanidina o l'acido guanidinsuccinico ed è meno grave dell'azione svolta dagli squilibri idro-elettrolitici frequentemente presenti quando la funzione renale è compromessa.
Poiché la massa delle unità funzionali di quest'organo è superiore alle necessità dell'organismo, l’IRC si rende manifesta quando il numero dei nefroni funzionanti si riduce ad un terzo. Le conseguenze della compromissione della funzione escretoria del rene, sono quelle comunemente indagate nel valutare la progressione dell'IRC ma, oltre i disordini del bilancio idro-elettrolitico, l'ipertensione arteriosa più o meno grave e la perdita delle funzioni endocrine renali, con conseguente riduzione nella produzione di eritropoietina e dei metaboliti attivi della Vitamina D3 entrano pressoché costantemente a far parte di questo quadro morboso.
Dialisi e IRA
La dialisi è un fenomeno fisico che consiste nel passaggio selettivo delle sostanze disciolte attraverso i pori di una membrana semipermeabile. Con tale sistema, si riesce ad ottenere l’allontanamento dal sangue delle sostanze nocive e il riequilibrio della concentrazione alterata dell’acqua e degli elettroliti. Pertanto essa si propose come terapia sostitutiva della funzione renale.
Willem Johan Kolff è, a buon diritto, considerato il padre del rene artificiale. Questo nasce infatti dagli esperimenti in corpore vivo condotti da questo geniale personaggio. Dopo numerosi tentativi falliti (una quindicina) senza che per questo il suo ostinato ottimismo venisse minimamente scalfito, egli riuscì, con l'uso di una ingombrante e complicata strumentazione, a far superare ad una donna di 67 anni un episodio di insufficienza renale acuta.
“Non sembra una grande idea” dissero subito i suoi numerosi detrattori. Infatti la miracolata era una riconosciuta collaboratrice dei nazisti e l'opinione diffusa (siamo nell’Olanda del 1945, di recente invasa dai tedeschi) era che sarebbe stato molto meglio che essa fosse stata lasciata al suo fatale destino.
I tempi erano però maturi per accettare questa invenzione e da quel momento, nonostante il fatto che le condizioni dell'immediato dopoguerra rendessero precaria la ricerca scientifica e difficoltose le comunicazioni, l'entusiasmo per l'uso della dialisi si diffuse rapidamente e moltissimi medici lungimiranti di varia nazionalità raccolsero l'idea di Kolff, trasferitosi negli Stati Uniti, e vollero dare il proprio nome ai vari modelli di “rene artificiale” che furono messi a punto in quel periodo. Anche italiani! Chi scrive, per amor di patria, spera che non cada nell’oblio il glorioso Rene Artificiale di Dogliotti-Battezzati-Taddei.
In illo tempore, a causa della complessità tecnica e della laboriosità dell'accesso vascolare, la gestione del rene artificiale comportava, accanto ai protonefrologi, l’opera di una nutrita schiera di chirurghi, ingegneri, tecnici ed altri esperti di discipline non mediche. La Rianimazione, come disciplina autonoma, non era ancora nata, ma all'ammucchiata non mancarono gli anestesisti. Questi pionieri, tutti insieme, portarono il rene artificiale ad un utilizzo pratico nei tardi anni Quaranta. Esso fu usato inizialmente soltanto per casi disperati di insufficienza renale acuta, ma occorre riconoscere onestamente che i successi iniziali furono molto scarsi.
Non tutti erano d'accordo sul fatto che il rene artificiale fosse in grado di salvare vite umane, e il partito degli oppositori era piuttosto nutrito ed alquanto agguerrito. Le autorità scientifiche in campo nefrologico che seguivano la tradizione metabolica favorivano infatti le terapie dietetiche conservative, quantificate di recente. La resistenza opposta alla dialisi rappresentava in parte un ragionevole scetticismo sui risultati ottenuti, ma anche una preferenza nei riguardi di ciò che costituiva scienza nell’ambito della medicina e si contrapponeva alla tecnica.
Fu necessario attendere la guerra della Corea, quasi del tutto dimenticata ai giorni nostri, perché l'emodialisi venisse legittimata sul campo, è proprio il caso di dire, come trattamento efficace dell'insufficienza renale acuta.
Il trattamento dell’IRA non pone attualmente grossi problemi di ordine etico, almeno quando non entrano in gioco remore di tipo economico. E’ invece proprio sulla nascita storica del rene artificiale che potrebbe essere opportuna qualche considerazione, ma ciò non fa parte degli argomenti sui quali stiamo discutendo.
Dialisi e IRC
Nonostante i successi ottenuti nel trattamento dell’IRA, restava irrealizzato il sogno di riuscire a sostituire, per lunghi periodi, la funzione renale compromessa da malattie croniche. Per realizzare questo sogno si dovette aspettare ancora più di un decennio.
Siamo ormai all’inizio dei lontani anni Sessanta quando Scribner, un nefrologo che lavorava a Seattle, affrontò, risolvendolo, questo problema. Due accorgimenti resero possibile questo risultato:
· * l’adozione di dializzatori di minor capacità che non richiedevano un pre-riempimento con sangue di donatore (il famoso rene artificiale a piastre di Kiil);
· * la messa a punto, da parte di Quinton, di uno shunt artero-venoso che consentiva un accesso vascolare agevole e, soprattutto, ripetibile nel tempo. Qualche anno dopo lo shunt fu sostituito vantaggiosamente dalla fistola artero-venosa realizzata da Cimino e Brescia.
All’inizio si trattò, più che di tecnologia sofisticata, di una sorta di “fai da te” condotto da una strana razza, ormai quasi totalmente estinta, che potremmo definire “i bricoleurs della dialisi”. Essi costituivano una sottospecie dell'homo faber, e i suoi componenti, non molto numerosi, raccolsero e svilupparono le idee della stravagante scuola di pensiero che abbiamo visto fare capo a Kolff, la quale sosteneva che la funzione renale potesse essere sostituita da qualche foglio di cellophan, opportunamente configurato e assemblato, e da alcune sostanze disciolte nell'acqua in determinate proporzioni.
Una follia! Ma alla luce dei risultati funzionò.
Fu in quel periodo che il trattamento dialitico nei nefropatici cronici entrò nel mondo medico come un modello terapeutico assolutamente innovativo, che consente non solo la sopravvivenza a lungo termine, ma anche condizioni soddisfacenti di vita.
Fin dall’inizio, all’emodialisi si è efficacemente affiancata la dialisi peritoneale che ha, anch’essa, una lunga storia alle spalle, ma che non è il caso di affrontare in questa sede.
Considerazioni etiche quando si inizia il trattamento dialitico
A differenza di quanto accadde per il trattamento dell’IRA, la nascita della dialisi nei cronici, dal punto di vista tecnico, non ebbe una gestazione tribolata. Tuttavia nessuno immaginava lo sviluppo che questo tipo di trattamento avrebbe avuto nel volgere di pochissimi anni, né le implicazioni etiche a cui diede origine fin dal suo nascere.
L’insufficienza numerica delle strutture e delle persone rispetto alla domanda si dimostrò subito drammatica. Avendo vissuto le esperienze di quel periodo posso testimoniare l'affannosa ricerca di apparecchiature, di locali contesi a magazzini e scantinati, delle precarie sistemazioni per i pazienti, lontane anche centinaia di chilometri e le innumerevoli drammatiche condanne a morte involontariamente inflitte, inventando controindicazioni alla dialisi che non si aveva la possibilità di praticare: l'età avanzata (Figuriamoci! Quarantacinque anni!)... le condizioni cliniche... le scarse possibilità di recupero...
Il pensiero che si potesse arrivare al pieno trattamento pareva un'utopia, eppure, alla fine degli anni 70, sembrò che esso potesse diventare una realtà, e il problema dell'uremia cronica sembrò essere stato affrontato in maniera giusta ed avviato ad una conclusione positiva.
E’ stata, quella, l’epoca del sogno ingenuo. La dialisi era vista come una specie di serena zona di parcheggio, talora addirittura gioiosa, frequentata da persone che dovevano subire il peso e la remora di qualche inconveniente ma che per il resto potevano condurre una vita del tutto normale, con il supporto adeguato di una tecnologia innovativa. Le ore improduttive della seduta dialitica potevano essere utilmente impegnate nella lettura, nello studio, nella conversazione o nell’ascolto di musica. Le complicanze che si verificavano nel corso della dialisi, sembravano destinate a scomparire col perfezionarsi delle metodiche e, per le anomalie non correggibili con il trattamento dialitico, si stava cercando con successo una terapia farmacologica.
Il trattamento poteva andare avanti a lungo, ma ci si diceva convinti che il flusso di pazienti immessi in dialisi sarebbe diminuito col tempo, per la messa a punto di misure preventive efficaci e di terapie innovative per guarire le nefropatie mediche. La dialisi non sarebbe scomparsa del tutto, perché c’è sempre una minoranza che non segue i principi e le prescrizioni di una politica sanitaria lungimirante. Ma il trapianto renale avrebbe assicurato il regolare svuotamento di questo serbatoio di ammalati e la dialisi, come esclusiva soluzione terapeutica, sarebbe rimasta limitata a pochi, pochissimi malati.
La realtà è stata, purtroppo, ben diversa. La dialisi, negli ultimi venti anni ha perso lo slancio iniziale ma il perfezionarsi della tecnologia consente oggi di trattare pazienti che una volta si vedevano sbarrata la via, per età o condizioni cliniche particolarmente precarie.
L’ampliamento delle indicazioni e dei limiti di età e la riduzione della mortalità in molte malattie, come cardiopatie e diabete, oggi consentono ad un maggior numero di pazienti di raggiungere l’uremia terminale ma, d’altro lato, dializziamo oggi una popolazione sempre più vecchia, sempre più fragile, sempre più a rischio. A causa di patologie vascolari, le amputazioni degli arti sono sempre più frequenti. Negli Stati Uniti circola la macabra battuta che nei centri dialisi ci sono più teste che gambe. E quest’esercito di zombi, com’è stato definito, sgarbatamente ma senza allontanarsi troppo dalla realtà, è destinato ad ingrossarsi. La scelta moralmente nobile del pieno trattamento rischia di trasformarsi in una beffa e, a volte, si ha l’impressione che dialisi e trapianto renale si trasformino in tecniche crudeli per uccidere malati terminali lentamente e in modo macabro.
E, a questo punto, entrano anche e pesantemente in campo considerazioni economiche.
Abbiamo attualmente una situazione in cui i costi del pieno trattamento dialitico stanno inghiottendo gli utili. E' questo uno dei motivi per cui la dialisi è rimasta un trattamento per paesi ricchi, quelli che fanno del denaro il fine di tutto.
Anche nei paesi del Terzo Mondo i ricchi possono permettersi la dialisi, per quanto sia per loro molto più conveniente il trapianto da donatore vivente, scavalcando ogni remora d’ordine morale perché se un’azione, per quanto abbietta, reca vantaggio a qualcuno ed è fattibile, in un modo o nell’altro si trova sempre una giustificazione per farla.
Ma che cosa si può fare per il terzomondista povero, con reni malati e quindi, oltretutto, non commerciabili? Posto il problema, ecco la risposta che mette tranquille le nostre coscienze non troppo schizzinose: la dialisi gastrointestinale.
Spiego subito di che si tratta: il paziente siede su una sorta di confortevole bugliolo, fatto di morbida plastica trasparente, in modo da monitorare opportunamente a vista il volume dei liquidi scambiati, e viene fatto bere molti litri di una soluzione di mannitolo. Chi ha avuto la ventura di eseguire una pancolonscopia sa di che cosa si tratta e quanto sia poco attraente questo lavaggio interno dell’intestino, che viene qui presentato come un flusso rigenerante che dall’orifizio orale raggiunge rapidamente l’orifizio aborale, allontanando le tossine uremiche. Ma uno dei guru della dialisi, sostiene: “Questo metodo è stato ampiamente usato a Taiwan. Nei paesi del terzo mondo, dove scarseggiano i finanziamenti per la dialisi, questo metodo può essere sostenuto”.[1]
Considerazioni etiche alla fine del trattamento
Il rifiuto del proseguimento del trattamento dialitico da parte del paziente in dialisi oppure l’esplicita richiesta di una sua interruzione, rappresentano casi estremi di forte impatto etico. Debbo dire che questa è un’evenienza rara in Italia ma, stando alla letteratura, nei paesi anglosassoni, in particolare negli Stati Uniti, l’interruzione programmata del trattamento rappresenta una frequente causa di morte dei pazienti in dialisi.
Sto parlando di “esplicita richiesta” di interrompere una terapia che si dimostra efficace il che, lo si voglia o meno, si configura, nella coscienza del medico che ha in cura il paziente, come un aiuto o, quanto meno, l’approvazione di un atto suicida.
Ben diversa è la situazione dell’interruzione di un trattamento diventato ormai intollerabile per il paziente. In questo caso possiamo invocare l’astensione da un accanimento terapeutico. Ma tale è il timore delle conseguenze legali derivanti da un atto di omissione di soccorso, che in questi casi, si preferisce ad una franca sospensione del trattamento, un comportamento ipocrita e una surrettizia diminuzione dell’efficacia di trattamento. Si comincia col diminuire le ore del trattamento. Si passa da un ritmo trisettimanale ad un ritmo bisettimanale, si abbonda coi sedativi e si aspetta che la natura provveda a concludere la vita del paziente in modo indolore. Naturalmente è un sistema sicuramente indolore per la coscienza del medico. Se però il curante rifiuta di illudere se stesso con ambigue giustificazioni e assume con coraggio la responsabilità delle proprie azioni, deve ammettere che interrompere la dialisi è come far morire una persona sottraendogli il cibo.
Le cure palliative in ambito nefro-urologico
Questo lo scenario in campo nefrologico. La domanda che a questo punto ci si pone è: “Come si configurano le cure palliative in questi scenari?”
Mi sia consentita qualche riflessione. Il termine palliativo deriva dal latino pallium, che era un mantello di cui facevano uso i pellegrini durante i loro viaggi verso i santuari, per proteggersi dalle intemperie. Analogamente le cure palliative hanno lo scopo di proteggere il malato nella sua globalità, durante quello che può essere l’ultimo tratto della sua vita.
Le cure palliative si caratterizzano per la globalità dell’intervento terapeutico che, avendo per obiettivo la qualità della vita residua, non si limita al controllo dei sintomi fisici ma si estende al sostegno psicologico, relazionale, sociale e spirituale. Palliative sono tutte le cure destinate a migliorare la qualità della vita e non orientate a controllare il processo evolutivo della malattia.
Nell’uso corrente il termine palliativo stenta a liberarsi da una connotazione negativa, un significato di inutile o inefficace. Al contrario le cure palliative proteggono il malato dalle sofferenze evitabili, salvaguardano la dignità della persona e sono le sole veramente utili per il malato morente.
Alla luce di queste affermazioni vengono a cadere due vincoli originari che, a mio modo di vedere, limitano e possono addirittura svilire il concetto che la gente ha delle cure palliative. Mi riferisco al legame, pressoché esclusivo, con la patologia oncologica e all’intervento terapeutico preferenziale sul dolore fisico. Con la caduta di questi vincoli le cure palliative possono e debbono guadagnare ampi spazi anche in campo nefro-urologico.
Trapianto renale
Uno sguardo al passato
All’inizio del secolo XX che entriamo nella storia reale dei trapianti d’organo. I tentativi cominciano proprio dal rene ma, come sarebbe successo per il rene artificiale, le prime fasi di questa nuova era furono piuttosto deludenti e barbare, costellate da una serie impressionante di insuccessi, ma anche da una caparbia e silenziosa perseveranza che, tra l’altro, permise di raffinare la tecnica chirurgica, di risolvere le difficoltà operatorie e di espandere le conoscenze sul sistema immunitario, tappa indispensabile per la messa a punto di terapie efficaci per contrastare il fenomeno del rigetto.
Da quel momento, la storia dei trapianti di rene si sviluppa trionfalmente lungo tre filoni principali:
- il trapianto da cadavere;
- il trapianto da vivente;
- lo xenotrapianto, quale oggi si ripropone insieme con la clonazione terapeutica, legati entrambi a manipolazioni genetiche molto discusse.
Ciascuno di questi tre filoni si è arricchito di rilevanti valori etici di riferimento che prenderemo in esame.
Trapianto da cadavere
Se oggi il trapianto da cadavere viene accettato dall’opinione pubblica senza grossi traumi, anzi quasi sempre con favore, negli anni a cavallo tra il Sessanta e il Settanta questa pratica impose scelte etiche impegnative, la necessità di una nuova e sconcertante formulazione della morte e la conseguente svalutazione del ruolo simbolico di cui è investito il corpo morto, molto forte specialmente nella nostra cultura. La forza delle emozioni suscitate da queste problematiche rendeva e talora rende ancora difficile un consenso immediato e generale a quest’approccio terapeutico.
In quell’epoca, abituati alle caute prese di posizione della Chiesa, molti si aspettavano una opposizione da parte delle autorità religiose cattoliche. Invece fin dall’inizio, sebbene molti siano ancora convinti del contrario, la Chiesa, per voce dei suoi più alti rappresentanti, si schierò ufficialmente senza esitazioni a favore dei trapianti d’organo. Tuttavia una presa di posizione così impegnativa doveva essere avallata da una giustificazione di forte peso morale. Ed ecco la soluzione presentata su un piatto d’argento a credenti e non credenti: la cultura della donazione. Il dono di un organo visto come un sublime atto di amore cristiano per i primi, come un nobile atto di filantropia per i secondi, come un’espressione di pietà, intesa nel senso più nobile, per entrambi.
La pietà appunto: un sentimento di partecipazione alla sofferenza altrui, religioso in senso lato, ma in cui si possono riconoscere credenti e non credenti, laici e confessionali. Che gli uni lo chiamino carità e gli altri solidarietà, non ha importanza. Aveva capito bene questo concetto il poeta Virgilio, ed infatti si parla di “pietas virgiliana”. Oggi usiamo questa espressione per definire quel sentimento che va addirittura oltre la pietà come noi comunemente la intendiamo. Un sentimento che, diventato coscienza, fa accettare la realtà anche se ciò comporta un cocente dolore.
Esiste però il rovescio della medaglia, cioè l’esatto contrario della pietas, che è l’empietà. Empietà è il comportamento di chi profana quanto è ritenuto sacro o morale. A mio modo di vedere, empio è, in Cina, il prelievo degli organi dei condannati a morte, uccisi pubblicamente con un colpo alla nuca in modo da non recar danno ad una merce preziosa, sollecitamente prelevata in un furgone attrezzato che staziona nelle immediate vicinanze. Empio, non soltanto criminoso, è il prelievo di organi eseguito su persone, specie bambini, uccise su ordinazione, di cui periodicamente si vocifera. Leggende metropolitane, dicono i puri di cuore. E’ auspicabile, ma dal momento in cui gli organi da trapiantare sono stati assimilati ad un bene commerciabile, ogni remora di tipo morale diventa sempre più fragile.
Trapianto da vivente
A rigor di termini, è soltanto nel trapianto da vivente che si può parlare, a pieno diritto, di donazione.
Dicono i filosofi, con ragione, che nel trapianto da vivente la donazione si configura come un “atto supererogatorio”, ossia “…implica un sovrappiù di coinvolgimento affettivo e di impegno etico”.[2] Sono in molti, compreso chi scrive queste note, a ritenere che nel campo dei trapianti da vivente il dono completamente spontaneo, libero e indiscutibilmente gratuito sia una cosa molto rara. E’ probabile che tale condizione si verifichi soltanto quando la donazione avviene dai genitori ai figli. Negli altri casi chi dona si aspetta sempre un riscontro, non fosse altro un po’ di gratitudine.
Tuttavia la donazione gratuita di un organo resta sempre un “atto d’amore”, anche quando è imperfetto. Quando è perfetto, cioè veramente libero, spontaneo e disinteressato, diventa un “miracolo d’amore”, che non è la stessa cosa. Oggi, come ieri, come tremila anni fa, facciamo un gran parlare di amore, nelle sue mille manifestazioni, ma il “miracolo d’amore”, come tutti i miracoli, è una cosa eccezionale, preziosissima e soprattutto non commerciabile. Non diamolo per scontato: è vero che i miracoli si realizzano anche ai nostri giorni ma essi, per definizione, sono un privilegio raro.
Da parecchi anni assistiamo invece ad una commercializzazione sentimentale degli organi alla luce dell'ideologia del trapianto. Ma se un bene di valore può essere ceduto da parte di chi lo possiede, è inevitabile che prima o poi diventi oggetto di mercificazione. Ed evito di proposito l'asettico termine di commercio, perché nel primo è più evidente il desolante scadimento di valori o di beni spirituali raffrontato all'interesse del guadagno che se ne può ricavare.
In un regime di libero mercato qual è il nostro, la carenza di organi da utilizzare a scopo di trapianto, in particolare di reni, non fa che aumentarne il valore, e soltanto gli ingenui continuano a pensare che la compravendita di organi possa essere tenuta sotto controllo.
“Non c’è disgrazia che non possa diventare un affare”, scrive Stefano Benni. Questo vale naturalmente anche, e soprattutto, per le malattie. I medici sostengono con ragione che non esistono più malattie incurabili, ma la filosofia del libero mercato spinge verso la cura più redditizia.
Xenotrapianto
La donazione di reni, sia da cadavere che da vivente, si dimostra insufficiente ogni giorno di più a soddisfare le richieste e, nonostante tutti gli sforzi, non riusciremo a risolvere il problema facendo affidamento soltanto su di essa. La via che si spera possa aprirsi con lo xenotrapianto non è dettata solo da curiosità scientifica ed entusiasmo per il progresso, ma anche dal desiderio virtuoso di venire incontro alle necessità di tutti coloro che necessitano di un trapianto d’organo.
Purtroppo, in questo caso, il rovescio della medaglia è pesante. A parte considerazioni utilitaristiche di sicurezza, che consigliano di procedere con molta cautela per la possibilità di trasmettere nuove malattie all’uomo, con lo xenotrapianto noi escludiamo gli animali dal nostro universo morale e riteniamo sia un diritto infliggere loro un’infinità di sofferenze per prolungare la vita anche di un solo essere umano.
Prima e durante il Big Bang del trattamento dialitico dei cronici, il trapianto renale, insieme con altre conquiste della chirurgia, raggiungeva i primi risultati positivi a spese di una vera e propria carneficina di animali e di persone. La mia impressione è che lo xenotrapianto, che esercita tanto fascino sui nostri moralisti, comporterà una carneficina di animali ancora maggiore.
Questi moralisti obiettano: in fondo i maiali, che sembrerebbero gli animali di prima scelta a questo scopo, sono già abbondantemente utilizzati per l’alimentazione: utilizzarli a scopo di trapianto è, in un certo senso, un modo di nobilitarli. Per filogenesi e cultura, nella nostra civiltà non c'è, nei confronti dei suini e, in genere, dei cosiddetti “animali appartenenti alla catena alimentare” quella carica emotiva, sentimentale, se vogliamo, che l'uomo prova e ha sempre provato nei confronti di altri animali, tradizionalmente considerati più vicini alla specie homo sapiens. Che cosa sono allora questi rigurgiti sentimentali? Da sempre li abbiamo allevati, i maiali intendo, per farne prosciutti, salami e mortadelle.
Ci troviamo insomma di fronte ad un paradosso perché proprio un elementare principio di giustizia “vuole […] rispettato il diritto al godimento del bene della vita da parte di ogni essere animato”.[3] Ma, parafrasando Jeremy Rifkin, prevedo che ogni critica e ogni resistenza contro lo xenotrapianto verranno combattute dalle crescenti legioni di credenti, e verranno definite inumane, irresponsabili, immorali e forse anche criminali.
Gli antichi greci avevano un termine di difficile traduzione: hybris. Questa parola stava a significare la “violazione della misura, cioè dei limiti che l'uomo deve incontrare nel suo essere in relazione con altri uomini, con la divinità e con l'ordine delle cose” (Aldo Carotenuto).
Ogni qualvolta superi la misura del giusto, e potrebbe essere il caso dello xenotrapianto, l'uomo cade nella hybris. Le prospettive offerte dallo xenotrapianto sono allettanti, ma non c’è il rischio che si stia prendendo una direzione che avrà come effetto un aumento anziché una diminuzione del dolore del mondo?
Dal presente uno sguardo al futuro
Esiste una “Vulgata” ampiamente accreditata che, nella cura del nefropatico cronico, identifica nella dialisi tutto il male e nel trapianto tutto il bene. La dialisi gode, insomma, di una pessima reputazione.
Nei settimanali e nella stampa divulgativa in genere, fotografie di pazienti in dialisi vengono spesso usate come illustrazione di situazioni negative: cura dei malati terminali, scarsa allocazione delle risorse, ecc. I trapiantati invece hanno un trattamento diverso: partecipano a gare olimpiche e vincono maratone. Ma le cose stanno veramente così?
E’ naturale che i dializzati, come in genere tutti i malati cronici, si sentano traditi dalla natura: soltanto i mistici godono delle proprie sofferenze. Ma, generalmente, chi entra in dialisi dirotta rapidamente verso altri obiettivi e interessi le energie derivanti dalle preoccupazioni che prima condivideva con le persone cosiddette sane.
Si fa un gran parlare del “calvario” della dialisi ignorando che, non infrequentemente, anche la vita del paziente trapiantato non è un giro di valzer perché il trapianto ha, in genere, una durata limitata nel tempo e non rappresenta in nessun caso la guarigione della malattia.
Le sfide che la scienza e l’etica si trovano ad affrontare nel secolo che è appena iniziato sono tremende e affascinanti. Però, incantati dalla chimera del trapianto, non dimentichiamo che è doveroso cercare la soluzione dei problemi ancora irrisolti seguendo anche altre vie: cioè quella della prevenzione e della terapia farmacologica delle malattie che portano al trapianto, vie che oggi purtroppo, almeno per quanto riguarda il rene, mi sembrano condotte in maniera fuorviante.
Da questo punto di vista le cose non sono cambiate molto in quarant'anni. Il fatto che l'incidenza annuale dei nuovi pazienti messi in dialisi continui ad aumentare può avere molte spiegazioni. Due fatti però non si possono negare:
a) mancano tuttora cure efficaci per evitare che la maggior parte delle nefropatici cronici arrivi alla dialisi;
b) il trapianto renale non è attualmente in grado di svuotare il serbatoio di pazienti in trattamento dialitico.
Una quantità enorme di risorse è stata e continua ad essere impegnata per il trattamento dialitico. C'è da chiedersi se i risultati sarebbero stati diversi qualora queste risorse fossero state distribuite diversamente nella prevenzione e nella ricerca orientata sulle cause delle nefropatie e sul modo di curarle.
Invece che cosa si è fatto in questi campi?
Allo stato attuale delle nostre conoscenze la nefrologia non possiede ancora il segreto della guarigione per la maggior parte delle malattie di sua competenza ed è ancora in attesa di una scoperta che rivoluzioni la terapia come è avvenuto per l’ulcera gastroduodenale. Essa riesce solo a fornire diagnosi raffinatissime e poi sta a guardare quel che succede, e le malattie renali che guariscono oggi guarivano anche quaranta anni fa, mentre quelle che evolvono verso la cronicizzazione e la necessità di dialisi e trapianto, si comportavano allora nello stesso modo, soltanto più rapidamente e con un profitto nettamente inferiore per il mercato.
Lo sbocco del trapianto non ha finora raggiunto il suo scopo, né lo raggiungerà facendo solo affidamento sul prelievo da cadavere. Sembra peraltro che la campagna per il trapianto da viventi, consanguinei e non, stia portando danni sproporzionati ai benefici, stando almeno a recenti notizie. La realtà è che esiste oggi un triage nel trapianto renale che ricorda da vicino quello della dialisi nei pazienti cronici ai suoi albori.
Mi sia consentito perciò di concludere citando una frase di Giorgio Cosmacini, dal suo libro “Il mestiere del medico”:
“I trapianti d’organo […] costituiscono certamente una grande
conquista della scienza applicata, oltre che, in molti casi,
dell’umana solidarietà. Ma, in molti casi, tale vittoria della terapia
è anche una doppia sconfitta della prevenzione:
quella di non aver saputo evitare [o guarire] la malattia
che induce la necessità del trapianto nel soggetto ricevente
e quella di non aver saputo evitare la morte incidentale del
soggetto donatore.”
Stiamo insomma passando dall’ideale ingenuo ma generoso degli anni Settanta ad un ideale più razionale ed evoluto certamente, ma con un’inevitabile ed evidente impronta monetarista. Per quel che ne posso intuire il futuro per molti sarà difficile da digerire.
[1] Oreopoulos D.G.: “Use of biological membranes in the removal of toxins from blood: from antiquity to present time”. Lettura Magistrale tenuta al X Congresso Nazionale sulla Dialisi Peritoneale. Torino, 27-29 maggio 1999.
[2] L.Battaglia: “Lo xenotrapianto in un’etica interspecifica”, in L’Arco di Giano, n.21, 1999.
[3] F.Voltaggio: “Il rapporto dell’uomo con gli animali”, in L’Arco di Giano, n.21, 1999.